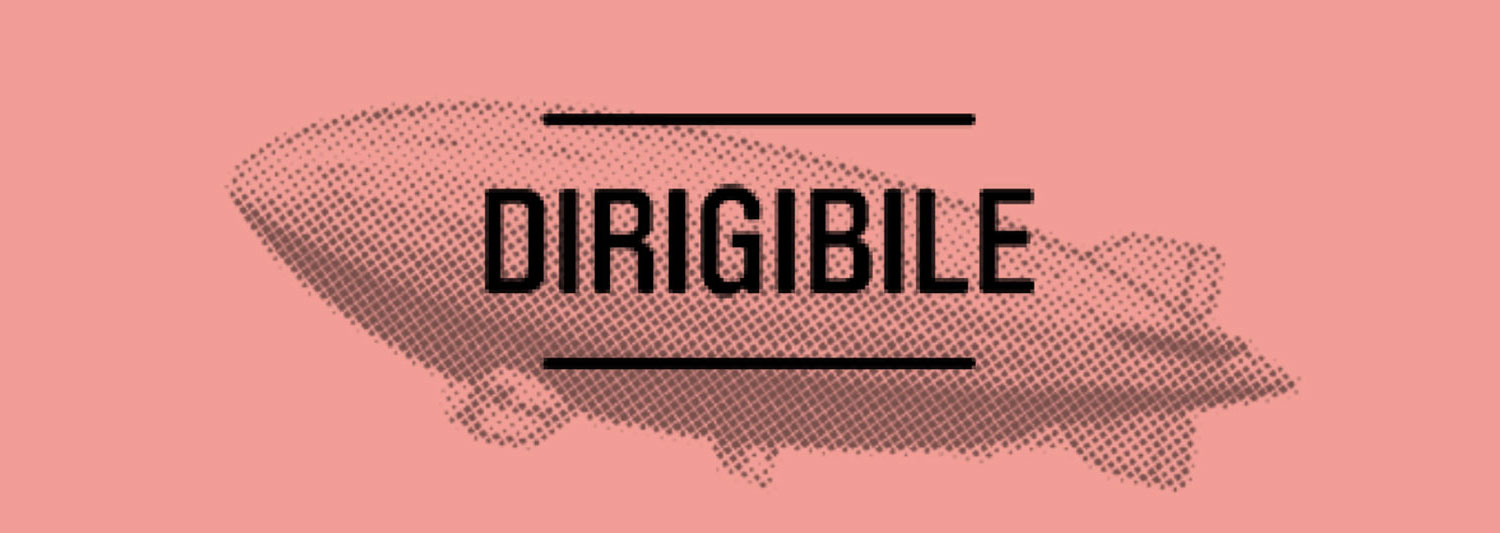Cosa c’è che non va nel modello di leadership americano? E come potremmo sostituirlo con un modello mediterraneo? Ne parliamo con Andrea Granelli (foto in alto), coautore con Elena Granata, del saggio “Anima mediterranea. La leadership come arte della guida”. Granelli è esperto di innovazione, leadership e digitale. Già presidente dell’Archivio Storico Olivetti, è fondatore della società di consulenza Kanso. Scrive per riviste di management e ha pubblicato diversi libri sulla leadership, il management, la trasformazione digitale e la formazione.
Cosa l’ha spinta a scrivere questo libro e perché ha scelto di ripartire dall’“anima mediterranea” come chiave per ripensare la leadership?
«Il punto di partenza è duplice. Da una parte un mondo in continua trasformazione… una trasformazione che non è una somma di comportamenti prevedibili ma un cumulato di crisi, che non si limitano solo a porsi ma interagiscono creando ulteriori dinamiche imprevedibili. Tant’è vero che si incomincia a parlare di policrisi.
Dall’altra i modelli di leadership prevalenti, quelli a trazione anglosassone, fatti propri e diffusi dalle principali business school.
Questi modelli stavano già mostrando il fianco per la loro incapacità di gestire la complessità e, soprattutto, le dimensioni soft, e per la loro progressiva indipendenza dal pensiero morale… o meglio, orientate esclusivamente dall’“etica degli affari”.
E quando il futuro si fa incerto, è sempre utile guardarsi indietro, rileggere la storia, e fare tesoro di quanto abbiamo a portata di mano che però abbiamo semplicemente ignorato perché non in linea con il pensiero mainstream.
Qui entra il Mediterraneo, inteso come “fabbrica per creare civiltà” per usare la felice espressione di Paul Valéry. Un Mediterraneo inteso come elemento culturale prima che come luogo geografico, come rifletteva Fernand Braudel nella sua introduzione al “Mediterraneo”: «Che cos’è il Mediterraneo? mille cose insieme. Non un paesaggio, ma innumerevoli paesaggi. Non un mare, ma un susseguirsi di mari. Non una civiltà, ma una serie di civiltà accatastate le une sulle altre».
Nel libro parla di “trasformare la leadership in arte della guida”. Cosa significa concretamente? Quali sono le differenze rispetto ai modelli tradizionali?
«Come scrive Antonio Spadaro S.I. nella prefazione “guida non è colui che precede, ma colui che accompagna. Non colui che trascina, ma colui che apre sentieri”.
E guidare significa «assumere la complessità come materia prima. Riconoscere che la realtà non è riducibile a numeri o indicatori, che i contesti contano, che i corpi sentono, che le parole pesano.
Significa capire che l’arte della guida è fatta di misura, di attenzione, di cura. Che non c’è guida senza un’etica della presenza, senza una politica dell’ascolto».
Lei afferma che i modelli di leadership anglosassoni sono ormai consumati. Quali sono i loro limiti e quali alternative propone?
«Il management scientifico e l’ossessione per il dato (che ha marginalizzato intuizione e fattori umani), il taylorismo (che ha sacralizzato standardizzazione ed efficienza), la crescita-dimensionale-a-tutti-i-costi (che non può adattarsi a tutti i contesti e tutte le tipologie aziendali), l’innovazione disruptive (che sconquassa, tagliando i ponti con il passato, e rischia di trasformarsi da mezzo in obiettivo fine a se stesso), l’internazionalizzazione sfrenata (non solo commerciale ma anche produttiva… che ha fatto riemergere l’orgoglio identitario e nuove forme di sovranismo), l’iper-finanziarizzazione (che ha promosso i dividendi a indicatore principale del valore di un’azienda) e la bellezza considerata lusso e spreco. Questi valori hanno oramai mostrato il fianco e in molti casi stanno diventando svantaggi competitivi».
In che modo la cultura mediterranea può offrire strumenti e valori utili per affrontare la poli-crisi che descrive?
«Il fulcro della cultura mediterranea è la sapienza, che è molto più della conoscenza dei dati e degli algoritmi. La sapienza dà corpo alla potenza del femminino e aggiunge al pensiero calcolante, al logos razionale e tutto maschile, il pensiero laterale guidato dal femminino, la metis fatta di arguzia, di gusto per la bellezza, di intuizione, di intelligenza emotiva, di pensiero critico, di senso della giustizia… che si muove a suo agio in situazioni complesse, in ambienti ambigui, tra conflitti e contraddizioni… senza però mai perdere purpose e direzione».
Nel libro parla di poli-crisi: quali sono, secondo lei, le tre trasformazioni più critiche che i leader devono affrontare oggi?
«La rivoluzione digitale, con i suoi sempre più rilevanti lati oscuri, l’età dell’inquietudine amplificata dal crescente disagio emotivo e il disengagement soprattutto dei giovani».
Riprende la massima di Juan Bonifacio: “La formazione della gioventù trasforma il mondo”. Qual è oggi il ruolo della formazione per i leader e come deve cambiare?
«Assolutamente centrale. Quando il contesto in cui operiamo si trasforma, le competenze che possediamo e l’esperienza maturata non sono più sufficienti. Inoltre, le nuove frontiere del digitale (soprattutto i dati e l’intelligenza artificiale generativa) stanno dimostrando che le competenze necessarie per padroneggiarle vanno molto oltre quelle tecniche.
Più che formazione parlerei di sviluppo delle persone, e le tre parole chiave che ridefiniscono secondo me un nuovo approccio all’apprendimento sono: traducibilità, memorabilità, e trans-disciplinarietà (vedi “Oltre la formazione”)».
Lei mette in guardia dall’“innovazione a tutti i costi”. Come si può trovare un equilibrio tra innovazione e rispetto della tradizione?
«È un tema che le aziende familiari conoscono molto bene: il legacy familiare è quel meccanismo in grado di accumulare, conservare e rendere disponibile alle future generazioni le esperienze, genialità e sensibilità degli antenati virtuosi, i capi-famiglia che diventano fondatori carismatici di una dinastia.
La tradizione non è dunque solo vuoto-a-perdere. Lo ribadisce in modo potente Gustav Mahler: “Tradizione non è culto delle ceneri ma custodia del fuoco”».
Quanto la rivoluzione digitale e l’IA stanno cambiando il modo di esercitare la leadership? Opportunità o minaccia?
«Siamo agli esordi del fenomeno per cui è difficile dare raccomandazioni precise; dobbiamo sospendere il giudizio ed osservare. Certamente la pratica manageriale cambierà molto ma non è ancora chiaro in quale direzione.
Una cosa è certa: le competenze necessarie per padroneggiare queste nuove frontiere del digitale non sono solo tecniche ma anche umanistiche (retorica, pensiero critico, intelligenza emotiva… )».
Quali competenze chiave deve sviluppare oggi un leader per essere un “artefice del cambiamento” e non subirlo?
«Il cambiamento – come il digitale – è un pharmakon, concetto con cui gli antichi Greci indicavano fenomeni complessi e sfaccettati, che potevano essere sia opportunità che minacce (infatti la parola significa sia farmaco che veleno… ).
Ancora un concetto nato nel Mediterraneo che ci suggerisce competenze sofisticate, capaci di integrare la conoscenza tecnica e quella manageriale, il logos con il pathos, il mascolino con il femminino… in un gioco di apparenti contrasti che invece producono nuove sintesi e comprensioni».
Se dovesse sintetizzare in una frase il cuore del libro, quale sarebbe? E quale auspicio ha per chi lo leggerà?
«Lasciamoci guidare dalla sapienza e ritorniamo a fidarci anche del nostro cuore e del nostro intuito, con l’auspicio di riscoprire la potenza dell’umano in un mondo sempre più pervaso dalla tecnica, dai dati e dagli algoritmi».