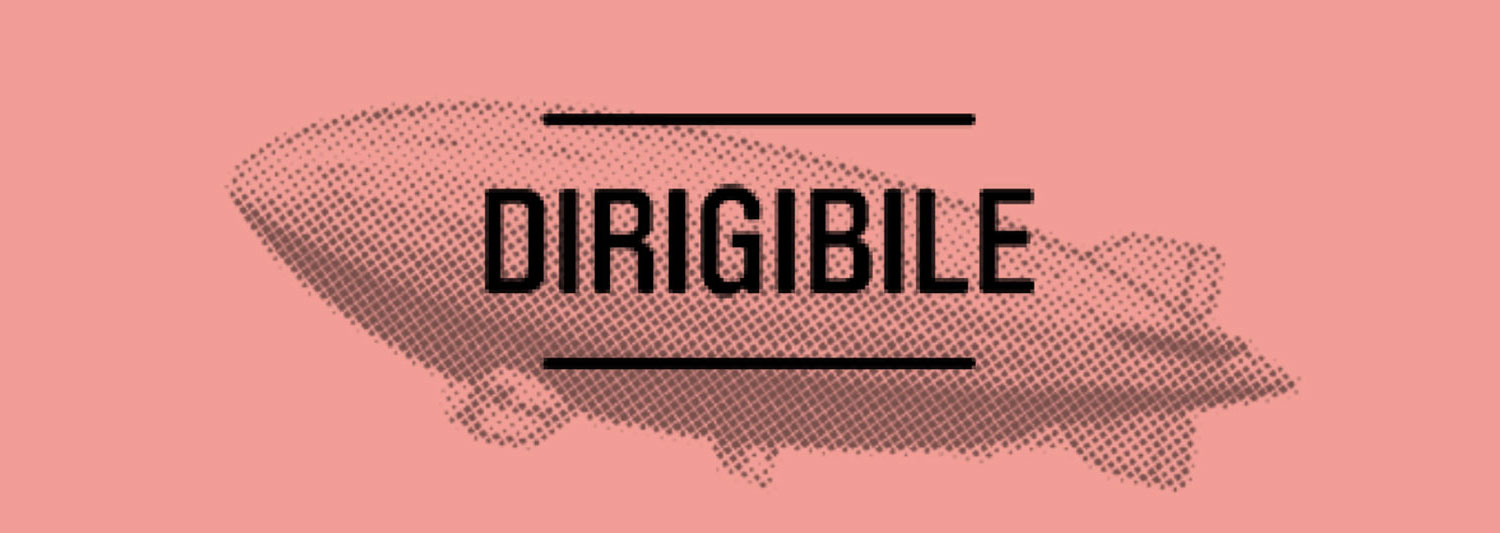Durante il Next Think Tank di Cfmt del 7 maggio, gli autori di The Unknowledge Economy hanno presentato il paper commentando il contesto che li ha spinti a scrivere il volume e fornendo ai presenti alcuni spunti utili a leggere presente e futuro con occhi nuovi.
Bulimia cognitiva e conformismo del pensiero
Aprendo i lavori, Thomas Bialas ha affermato che «viviamo in un’epoca di bulimia cognitiva: siamo aggrediti da tantissime informazioni, che però non abbiamo il tempo di digerire e leggere con spirito critico». Questo ci porta ad essere «conformisti della conoscenza» e a non reagire a fenomeni come la censura o il pensiero unico. «Tutto questo – ha concluso Bialas – in aggiunta alle novità digitali come l’intelligenza artificiale che, di sicuro, non aiuta a comprendere la realtà, favorirà una crisi identitaria, oltre a quella sociale».
La crisi epistemologica è anche economica
Luca De Biase ha poi commentato la crisi epistemologica in cui ci troviamo, causata dal fatto che non sono più gli accadimenti a guidare le opinioni, bensì il contrario: il sistema mediatico crea un’opinione, che poi diventa un fatto, la realtà. «Ma come si fa a prendere decisioni – si chiede De Biase – se non si sa davvero come stanno le cose? Ecco che la risorsa, anche economica, di questo tempo è la conoscenza; la crisi epistemologica che viviamo, infatti, è anche una crisi economica».
Allenare lo sguardo sul futuro
Nel suo intervento, Andrea Granelli ha fornito ai manager alcuni suggerimenti per allenare il proprio sguardo sul futuro, che si manifesta sempre con indizi significativi: «Primo: dedicate del tempo a organizzare la conoscenza e ad allenare la memoria, magari aiutandovi con il digitale. Secondo: esercitate l’arte combinatoria. Da un lato, allenatevi a trovare e costruire le connessioni tra oggetti/informazioni per dare senso alle cose, dall’altro decostruite e sviluppate il pensiero critico. Terzo: lavorate sugli oggetti di conoscenza, come immagini e aforismi, che sono sempre utili per fissare i concetti e rendere “memorabile” la conoscenza».
Il design thinking come strumento cognitivo
Infine, raccontando la nascita di alcuni celebri pezzi di design, Marco Tortoioli Ricci ha mostrato come il design thinking sia uno «strumento utile a ripensare concetti, azioni e relazioni». Proprio secondo queste logiche è stata strutturata la “un-exercise room”, la sezione finale del paper The Unknowledge Economy, che contiene utili esercizi per disimparare quello che si sa e fa e guardare al mondo, all’azienda e al lavoro con occhi nuovi.
Kill skill: imparare disimparando
Hanno chiuso i lavori Thomas Bialas e Nicola Spagnuolo, direttore Cfmt, con l’invito “kill skill”: «Per il futuro servono nuove competenze. Dobbiamo quindi uccidere quelle vecchie… imparare a disimparare tutto ciò che c’è di sbagliato, inutile, infruttuoso e superficiale di quello che abbiamo appreso fino ad oggi».
DI CHE SI PARLA QUI? SCUSATE IL RITARDO
2000. Il Millennium Bug c’è stato eccome. Non era informatico ma informativo, anzi, disinformativo. Puro disordine della conoscenza e condivisione della scemenza. Dunque, uno “scemario” futuro su cui riflettere
Thomas Bialas, futurist
Chi cerca trova. Noi non abbiamo cercato ma abbiamo trovato. La tavola era già bella che apparecchiata. Si trattava “solo” di osservare il comportamento dei commensali e magari prevedere le portate in arrivo e le future digestioni o reazioni. Da tempo qualcosa non quadrava. Lo sentivi nell’aria. La tanto celebrata economia della conoscenza, espressione coniata da Peter Drucker, con la quale si intende l’utilizzo delle informazioni e conoscenze per generare valore, stava diventando un disvalore o, meglio, il caos.
Tutto ebbe inizio nel 2000. All’alba del nuovo secolo. Ve lo ricordate? La paranoia del grande bug. Il bug c’è stato, in effetti, e ha mandato in tilt la conoscenza futura. Paradossale, vero? Tutti a dirci che grazie a internet e al mondo digitale avremmo avuto accesso a una conoscenza sconfinata e condivisa. Un’immensa e assoluta biblioteca a disposizione di tutti. Siamo però sinceri, chi ne aveva veramente voglia? La solita élite. I soliti secchioni.
Per il resto è stata la classica o, meglio, la nuova rottura del vaso di Pandora digitale. Una vomitata over load tale da provocare il blocco del sistema cognitivo digestivo. Infatti, ora, tutta la scemenza e superficialità affliggono il grosso dell’umanità. Certo, TikTok, lo scrolling compulsivo e la dipendenza dall’intelligenza artificiale (che bello, pensa per me) erano a venire, ma già allora doveva, poteva, essere chiaro come andava a finire. Una babele dell’inconsistenza della conoscenza.
Poi, a seguire, in anni più recenti, vennero la sistematica falsificazione, manipolazione, confusione ed esagerazione dell’informazione supportata anche dall’IA o, meglio, dai deepfake e dall’onnipresente propaganda ora globalizzata ed equamente distribuita da tutti su tutto il pianeta. E, ora, eccoci qua a raccogliere i cocci della conoscenza.
Sorgono dubbi e domande. Se domina il regno del verosimile, che faccio? Che cosa è vero e cosa è falso? Che cosa è ancora autentico e genuino? Che cosa è veramente rilevante? Dove sono i messaggi affidabili? Quali fonti sono ancora attendibili? È l’inizio di una perdita di controllo dei contenuti? Di chi o cosa posso ancora fidarmi? Come posso riconquistare la mia sovranità cognitiva? E cosa può aiutare a contrastare questo fenomeno? In breve, l’inconsistenza della conoscenza ormai apparecchia tutte le tavole, anche i tavoli delle riunioni in preda al tormento della madre di tutte le domande: se non so più niente, come faccio a decidere? Ecco. È giunto il tempo di fissare il vasto problema e tema. Knowledge economy, unknowledge economy, nextknowledge economy.
Tesi, antitesi e sintesi. Una triade con fenomeni sovrapposti che si completano e distruggono a vicenda. Una tripartizione con cui ognuno deve fare i conti. In questa fase storica, ognuno di noi vive, volente o nolente, contemporaneamente nell’economia della conoscenza, dell’inconoscenza e della nuova conoscenza. Un giorno qua, un giorno là. Spesso, inconsapevolmente. Knowledge, unknowledge e nextknowledge. Inseparabili, ma, forse, superabili. E di questo che parliamo qui. That’s all folks. Resta però ancora una cosa da fare. Risorgere. Non più soft skills ma so oft skills. Così tante e così spesso. Abilità per la nuova era della prossima conoscenza.
Testo tratto dalla prefazione del volume The Unknowledge Economy. L’economia dell’inconoscenza. Se non so più niente, come faccio a decidere? scritto da Thomas Bialas, Luca De Biase, Andrea Granelli e Marco Tortoioli Ricci (pubblicato da Cfmt, edito da Franco Angeli Edizioni).
Ti ha incuriosito? Clicca questo link per scaricare la tua copia gratuita del libro The Unknowledge Economy.