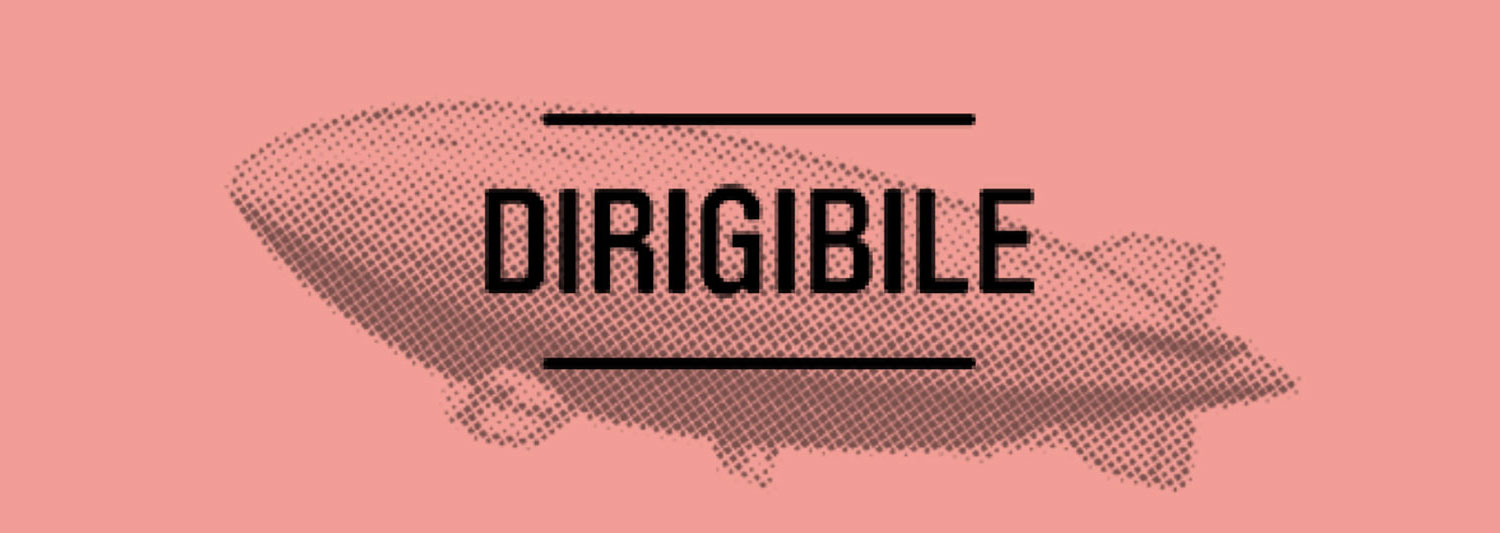L’evento “Why should I eat?”, organizzato da Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna e Umbria, proposto e ideato dal consigliere dell’associazione Gaetano Torino, ha offerto una riflessione profonda su come l’alimentazione possa diventare una leva strategica per il futuro del Paese. Svoltosi il 22 ottobre, ha riunito esponenti del mondo accademico, scientifico, imprenditoriale e manageriale per riflettere sul significato del cibo nel mondo contemporaneo. Fin dal titolo, volutamente provocatorio, si è voluto invitare a interrogarsi non tanto sul “cosa mangiamo”, ma sul “perché mangiamo”, stimolando un confronto tra cultura, salute, economia e tecnologia.
Cibo e responsabilità sociale
Il filo conduttore dell’incontro è stato il cibo come fattore di evoluzione e responsabilità collettiva. Già, perché in un’epoca segnata da transizioni climatiche, crisi sociali e innovazioni tecnologiche, il modo di produrre e consumare alimenti diventa una questione non solo economica, ma anche etica e culturale.
Come ha sottolineato Donatello Aspromonte, vicepresidente Manageritalia Executive Professional e professore Università Guglielmo Marconi, il cibo rappresenta il 19% del Pil italiano e incide su ambiente, giustizia sociale e salute. Parlare di alimentazione significa affrontare il cambiamento climatico, la distribuzione delle risorse e la sostenibilità della filiera. Quattro degli Obiettivi Onu 2030 riguardano il cibo, è occorre ricordare che la conoscenza e la consapevolezza sono strumenti chiave per costruire un futuro equo e sano.
Gli interventi dei relatori: innovazione, sicurezza, sostenibilità, manager
Piergiorgio Tupini, presidente dell’Accademia di Cultura Enogastronomica, ha aperto la tavola rotonda sottolineando la centralità della sostenibilità alimentare come condizione di sopravvivenza per l’umanità. Ha richiamato il valore etico della tradizione gastronomica italiana, auspicando che la spinta all’innovazione non cancelli l’identità culturale e i saperi artigianali: “speriamo di poter mangiare ancora la nostra carbonara anche nel futuro”.
Rosaria Marino, dirigente Asl, ha trattato il tema della sicurezza alimentare, distinguendo tra contaminazioni oggettive (microbiologiche, chimiche e fisiche) e rischi soggettivi legati a intolleranze e allergie. Ha sottolineato come l’Italia possieda una legislazione tra le più rigorose d’Europa in materia di sicurezza e tracciabilità del cibo.
Cinzia Miriam Calabrese, medico internista e nutrizionista, ha illustrato la dieta mediterranea come stile di vita sostenibile, riconosciuto dall’Unesco. Non solo uno schema alimentare, ma un modello di benessere che incide positivamente sulla produttività e sulla concentrazione: “se mangio meglio, lavoro meglio”. Ha ricordato l’importanza di una dieta equilibrata e conviviale, che riduca stress e malattie croniche.
Stefano Potortì, imprenditore nel Regno Unito, ha presentato un progetto innovativo di allevamento di grilli, volto alla produzione di proteine alternative sostenibili. Ha chiarito che queste fonti non intendono sostituire la dieta mediterranea, ma integrarla per rispondere alla crescente domanda di proteine di qualità, con attenzione a impatto ambientale e inclusione sociale.
Gabriele Belsito, Chief HR Officer di Eataly, ha offerto una panoramica sulle tendenze del food negli Stati Uniti: crescita del delivery, attenzione alla sostenibilità, all’healthy food e al contenimento dei costi in un mercato colpito da inflazione e carenza di manodopera. Ha illustrato nuovi concept come Eataly Café, che unisce la cultura italiana del caffè a una ristorazione moderna e leggera.
Roberto Costa, imprenditore e presidente della Camera di Commercio Italiana a Londra, ha condiviso la sua esperienza sulla leadership nel settore ristorativo. Costa ha evidenziato come autenticità, rapidità e storytelling siano oggi determinanti per il successo: “Non basta cucinare bene: serve raccontare una storia vera”, ha detto, invitando i giovani imprenditori a valorizzare l’identità italiana senza scendere nella guerra dei prezzi.
Salvatore Lorusso, professore all’Università di Bologna, ha riflettuto sul ruolo del manager nel settore agroalimentare, che deve evolversi da “tuttologo” a “event manager” capace di integrare cultura, innovazione e territorio. L’alimentazione, come l’arte, è parte del patrimonio culturale italiano: la memoria diventa futuro attraverso la valorizzazione sostenibile dei territori.
Gianfranco Piccioni, del Consiglio del Cibo di Roma, ha descritto l’impegno della capitale nella definizione di una food policy urbana basata su sostenibilità, riduzione dell’impatto ambientale e filiere locali. Roma produce solo il 5% del cibo che consuma: aumentare la produzione e la connessione tra agricoltura e ristorazione è una sfida strategica.
Rita Palumbo, esperta di internazionalizzazione, ha concluso spiegando perché le imprese italiane del food, pur eccellenti nella qualità, faticano a competere sui mercati globali. Mancano manager competenti e cultura d’impresa strutturata. Ha denunciato la tendenza delle microimprese a fare tutto da sole e a sostituire il sapere manageriale con strumenti improvvisati, invitando a investire in formazione e professionalità.
Cibo e consapevolezza: i 4 messaggi chiave per cambiare il nostro approccio
“Why should I eat?” non è stato un semplice convegno sul cibo, ma una riflessione multidisciplinare sul suo valore umano, economico e culturale. Dal cibo come atto vitale e simbolico, alla sicurezza alimentare, alla sostenibilità delle filiere e all’innovazione tecnologica, tutti i relatori hanno contribuito a un messaggio condiviso: nutrire il pianeta significa prima di tutto nutrire la consapevolezza.
Ecco allora i punti chiave emersi.
- Il cibo come questione globale, etica e culturale
Mangiare non è solo un atto biologico, ma un gesto economico, sociale e valoriale. Il cibo intreccia salute, ambiente, economia e cultura, incidendo sul 20% del PIL italiano e sul 25% delle emissioni globali. Parlare di alimentazione significa quindi parlare di futuro sostenibile, giustizia sociale e consapevolezza collettiva.
- Innovazione e sostenibilità: la nuova rivoluzione alimentare
Dalla dieta mediterranea alle proteine alternative e all’uso dell’intelligenza artificiale in agricoltura, emerge una transizione verso un cibo più efficiente, sicuro e rispettoso del pianeta. Innovare non vuol dire sostituire la tradizione, ma integrarla con tecnologia e ricerca, riducendo sprechi e impatti ambientali.
- Il ruolo decisivo dei manager e delle imprese
Il futuro del food richiede leadership competente e consapevole. Manager e imprenditori devono saper coniugare cultura, marketing, etica e sostenibilità. Non basta “saper fare”: servono visione, storytelling autentico e capacità di costruire filiere e reti. Il manager moderno è un “event manager” del territorio: collega economia, innovazione e valori.
- Competitività italiana: eccellenza sì, ma con metodo
L’Italia ha un patrimonio unico di biodiversità e qualità, ma soffre di frammentazione e scarsa managerialità. Per competere sui mercati globali, le imprese devono strutturarsi, internazionalizzarsi e comunicare meglio il proprio valore. Non si vince con il prezzo, ma con autenticità, cultura e professionalità.