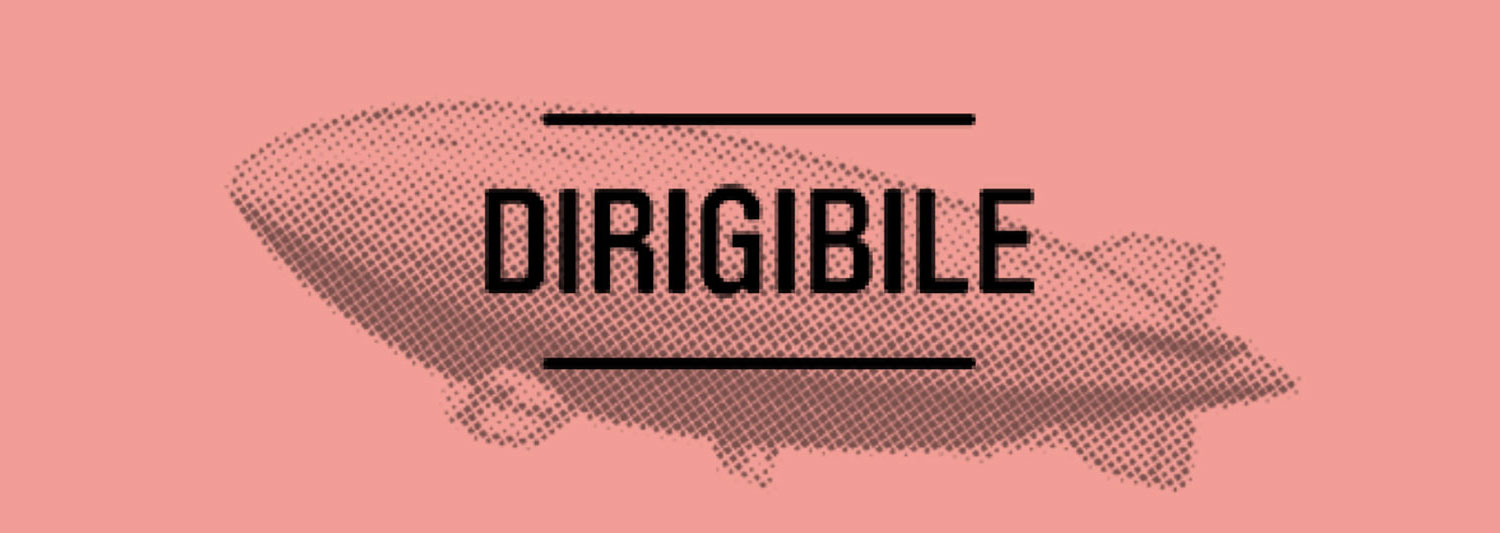Avv. Daniela Subani – Trieste
Associata Manageritalia Executive Professional
La realizzazione del Pnrr in Italia ha incontrato notevoli ostacoli, con conseguente mancata utilizzazione di parte dei fondi disponibili, ritardi e difficoltà nella realizzazione dei progetti. Inoltre, gli enti locali di dimensioni e struttura ridotte, quali piccoli comuni, non hanno avuto possibilità di aderire a bandi adatti alle specifiche esigenze del territorio, mancando in genere un effettivo coordinamento tra le diverse autorità e le amministrazioni locali.
Uno strumento del Pnrr
Il partenariato pubblico-privato (Ppp), che rappresenta una forma di collaborazione tra il settore pubblico e privato per la realizzazione di progetti per infrastrutture e servizi di pubblica utilità, è stato individuato dal legislatore, nell’ambito del Pnrr, come lo strumento “preferito” per attuare i progetti finanziati da tali fondi.
Tuttavia, i progetti da realizzarsi nel contesto del Pnrr costituiscono opere di rilevante entità economica, che in definitiva vengono poste ad oggetto di bandi – e conseguente aggiudicazione – di appalti di considerevoli dimensioni.
A tali gare partecipano, dunque, le grandi imprese, che possono contare su ingenti disponibilità economiche e la cui attività è connotata da un’abituale attitudine ed esperienza nella realizzazione di grandi progetti.
Flessibilità e opportunità per le Pmi
Diversamente, il partenariato pubblico-privato (Ppp), già previsto e regolamentato nel previgente Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016), poi sostituito dal nuovo Codice dei Contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023 e successivo correttivo), consente la realizzazione di progetti di pubblica utilità anche e comunque al di fuori delle strette regole dettate per il Pnrr.
Il Ppp, dunque, può essere di sicuro interesse e costituire una grande opportunità anche per le piccole e medie imprese, più legate ed attente alle necessità del territorio in cui operano, senza dover affrontare le gravi difficoltà di realizzazione del Pnrr.
Struttura e funzionamento del PPP
La fattispecie del PPP, e degli inerenti contratti di concessione, viene disciplinata agli artt. da 174 a 208 del Codice. Il partenariato pubblico-privato si realizza tra un ente pubblico concedente e uno o più operatori economici privati, attraverso un rapporto contrattuale di lungo periodo, per raggiungere un risultato di interesse pubblico.
Finanziamento e ripartizione dei rischi
La copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, che si assume il rischio operativo e ha il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre la parte pubblica definisce gli obiettivi e ne verifica l’attuazione.
Nelle ipotesi di Ppp l’ente concedente conferisce all’operatore economico un complesso di attività consistenti nella progettazione definitiva, realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione attiva di un’opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all’utilizzo dell’opera stessa.
Ambiti di applicazione
L’oggetto del Ppp può essere molto ampio, ma in generale si tratta di progetti che coinvolgono la realizzazione e/o la gestione di infrastrutture o servizi di interesse pubblico, in cui la Pa e il privato collaborano per finanziare, progettare, realizzare e/o gestire il progetto.
Quali esempi di costante realizzazione di Ppp vi sono: infrastrutture pubbliche (strade, autostrade, ponti, aeroporti, ferrovie, sistemi di trasporto pubblico, ospedali, scuole, asili nido ecc.; servizi pubblici (gestione dei rifiuti, illuminazione pubblica, approvvigionamento idrico, servizi sanitari, servizi educativi ecc.); progetti di efficientamento energetico (impianti di energia rinnovabile, impianti di produzione di energia ecc.); progetti di Ict (sistemi di comunicazione, servizi digitali ecc.); progetti di turismo (strutture turistiche, servizi turistici ecc.); progetti culturali (centri artistici, centri congresso, musei, arene ecc.); progetti sportivi (campus sportivi, strutture dedicate allo sport quali stadi, piscine ecc.).
In tutti tali ambiti il privato, che può essere rappresentato da un’unica azienda o da un pool di operatori economici riunti in una delle forme consentite (Ati/Rti, Società di Progetto – Spv) possono rendersi promotori della realizzazione di un’opera o di servizi innovativi di pubblica utilità.
I vantaggi del Ppp per pubblico e privato
Le procedure di Ppp offrono numerosi vantaggi sia per la Pa sia per le aziende private. Da un lato, la Pa può avvalersi di capitale privato per realizzare progetti che non sarebbero attuabili con le sole risorse pubbliche. Dall’altro l’azienda privata può godere di un contributo per le spese di realizzazione dell’opera normalmente fino al 49% (Iva inclusa) della spesa globale, oltre a ottenere una concessione di lunga durata per la gestione/sfruttamento dell’opera realizzata (20/30 anni).
Nei contratti di Ppp il rischio viene solo parzialmente condiviso tra la Pa e il privato poiché l’art. 177 (Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo) – post Correttivo – stabilisce espressamente che “Il rischio operativo, rilevante ai fini della qualificazione dell’operazione economica come concessione, è quello che deriva da fattori esterni non soggetti al controllo delle parti. Non rilevano i rischi connessi a cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali dell’operatore economico o a causa di forza maggiore”. Il rischio operativo va dunque individuato sia dal lato della domanda, sia dell’offerta.
Tipologie di partenariato e diritto di prelazione
Il Ppp può essere di iniziativa pubblica o privata. Nel Ppp di iniziativa pubblica, la Pa realizza in proprio un progetto e lo pone a gara finalizzata ad individuare e prescegliere il partner privato, mentre nel Ppp di iniziativa privata (art. 193 comma 3 del Codice) è il privato a proporre il progetto (Progetto di Fattibilità Tecnico Economica – Pfte) e a sottoporlo all’ente pubblico.
Procedura e tutela del promotore
L’operatore economico “promotore” che presenta all’ ente concedente (comune, Regione, altri enti pubblici etc.) una proposta per realizzare una certa “Opera” deve allegare: un progetto di fattibilità; una bozza di convenzione (con allegata “matrice dei rischi”); il piano economico-finanziario asseverato (Pef); la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, oltre all’usuale indicazione di possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale (avvalendosi eventualmente, anche integralmente, delle capacità di altri soggetti) del promotore.
A seguito della presentazione della proposta l’ente verifica la sussistenza dell’interesse pubblico, ne dà notizia sul proprio sito istituzionale indicando un termine non inferiore a sessanta giorni per la presentazione di altre proposte per il medesimo intervento da parte di altri operatori economici. L’ente concedente può richiedere di apportare al progetto di fattibilità, al piano economico-finanziario e allo schema di convenzione le modifiche necessarie per la loro approvazione. In caso di pluralità di proposte ammesse (caso non frequente) la procedura di valutazione si svolge in forma comparativa.
Va precisato che la configurazione giuridica del promotore, ovvero del proponente, può essere modificata e integrata sino alla data di scadenza della presentazione delle offerte in sede di gara e che nel bando l’ente concedente dispone che il promotore ovvero il proponente può esercitare il diritto di prelazione, entro 15 gg. dalla comunicazione dell’aggiudicazione.
In sostanza, se si presenta una proposta ai sensi dell’art. 193, 3 comma, in successiva sede di gara qualora ci fossero più partecipanti e venisse prescelto soggetto diverso dal proponente quest’ultimo ha il diritto di realizzare lui stesso l’opera alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario, il che è senz’altro un aspetto molto favorevole. In ogni caso se il promotore (ovvero il proponente) non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell’ingegno. L’importo complessivo delle spese rimborsabili non può superare il 2,5% del valore dell’investimento, calcolato sulla base del progetto di fattibilità posto a base di gara.
La società di scopo e la bancabilità del progetto
Per gli affidamenti sopra-soglia (euro 5.538.000 per gli appalti pubblici di lavori e per determinate concessioni) l’aggiudicatario deve costituire una società di scopo in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società di scopo si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso in cui siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, originari o subentrati.
In caso di proposta presentata da un gruppo di imprenditori riuniti in Rti, la società di scopo costituita post aggiudicazione subentra nel rapporto di concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione amministrativa.
Usualmente, per favorire la bancabilità dell’Opera e consentire al privato di ottenere adeguati finanziamenti (spesso mutui agevolati) nella bozza di convenzione da allegare alla proposta viene richiesto espressamente (qualora l’opera consista nella edificazione o restauro di un immobile) che l’ente conceda il diritto di superficie ai sensi dell’art. 952 e ss. del cod. civ. per tutta la durata della convenzione. In tal modo le banche concedono più facilmente i mutui richiesti potendo iscrivere ipoteca sul diritto di superficie.
Nei casi in cui, nel corso del tempo, l’equilibrio economico-finanziario venga compromesso o comunque vari sostanzialmente (in senso negativo o positivo) sono previsti vari meccanismi di aggiustamento in corso di esecuzione del contratto.
Esempi concreti: il caso Trieste
Per fornire degli esempi concreti già attuati nell’ambito della Provincia di Trieste si citano la realizzazione del Park S. Giusto, del nuovo Centro congressi in Porto vecchio e di “Trieste Campus” (grande centro sportivo con doposcuola) in partenariato con il Comune di Trieste, la realizzazione di svariati Ppp in tema di efficientamento energetico e illuminazione pubblica in partenariato anche con comuni minori. Ma nel panorama nazionale numerosi sono i Ppp aventi ad oggetto la resa dei più svariati servizi (da quelli di tesoreria, fiscalità a quelli in campo sanitario) resi in favore di enti pubblici e soggetti a Tariffazione, ovvero che prevedono il pagamento diretto da parte della Pa di corrispettivi predeterminati.
Perché le Pmi dovrebbero interessarsene
Un’azienda privata o un gruppo di privati può avere l’interesse e l’utilità di avviare, quindi, un procedimento teso alla presentazione di una proposta per realizzare un ‘opera (asilo nido per i propri dipendenti, case di riposo, centri sportivi, ricreativi, culturali ecc.) sfruttando i numerosi immobili fatiscenti o aree degradate che potrebbero tornare a nuova vita, permettendo di realizzare piccole e grandi opere utili alla collettività. Tali iniziative consentono risparmi economici, efficienza e qualità nella resa dei servizi, durata costante del rapporto contrattuale, gestione ottimale e attenta delle opere, perché il partner privato, oltre a mettere a disposizione risorse finanziarie, offre al soggetto pubblico le proprie competenze specifiche e il proprio know-how, il modello di business più appropriato per il buon esito del progetto, l’applicazione di figure altamente specializzate e di tecnologie avanzate costantemente aggiornate nel tempo.